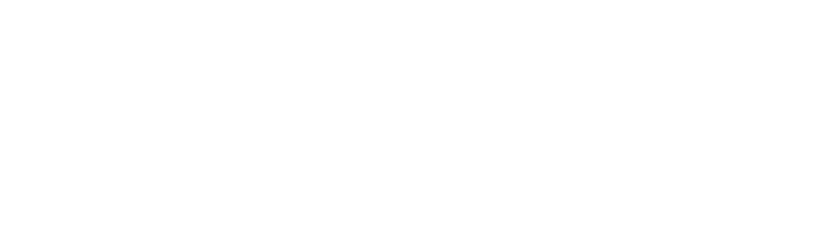 Sei un* docente?
Sei un* docente?
Partecipa con la tua classe all’open call
per le scuole secondarie di primo grado
della Regione Puglia
L'Emozionario Ambientale® è un dizionario che parte in Puglia come progetto partecipato che vuole spostare l’asticella della narrazione della crisi ambientale, dalla paura alla speranza, attraverso l’azione collettiva. In questa fase di partecipazione vogliamo coinvolgere i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio regionale, a visualizzare le parole chiave attraverso la loro creatività. I migliori elaborati saranno selezionati per far parte del primo prototipo che sarà lanciato a fine anno.
Partecipa con la tua classe!
Il nostro comitato scientifico ha stilato 30 parole chiave. Siete
invitati a selezionare una o più parole, e lavorare con gli studenti che possono rappresentarle in
modo artistico-creativo.
I lavori che si possono inviare sono: fotografie, illustrazioni, disegni o poesie.
L’open Call è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della Regione Puglia.
COME FUNZIONA
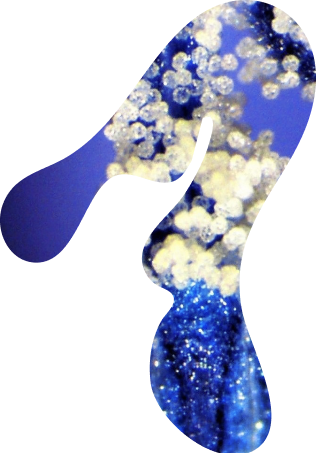
Seleziona le parole chiave
Trovi l’elenco delle 30 parole sotto, assieme
a una breve descrizione. Potrai stamparla e
condividerla
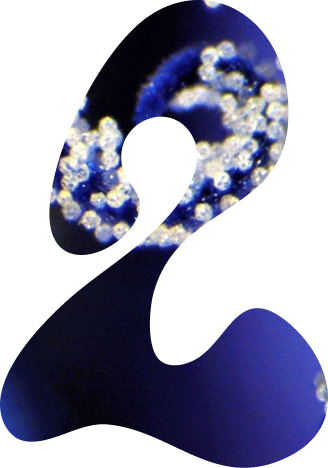
Interpreta la parola in maniera
creativa e artistica
I ragazzi hanno massima libertà creativa:
illustrazioni, fotografie, poesia,
disegni...sbizzarrisciti!
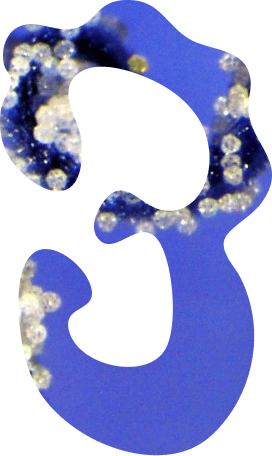
Invia gli elaborati!
Utilizza il form apposito, e carica
gli elaborati
entro il 30 maggio 2025
RACCONTACELO CON UN DISEGNO, UNA POESIA O QUALSIASI ALTRA CREAZIONE
SELEZIONE
E VALUTAZIONE
Il nostro comitato scientifico selezionerà i lavori più rappresentativi, che saranno inclusi nel prototipo finale dell’ Emozionario Ambientale®.
QUANTO TEMPO HO?
Hai a disposizione circa un mese!
La deadline è il 30 maggio 2025.
La mia classe può candidare più progetti?
Sì, sia la classe che gli studenti possono candidare più progetti legati alle singole parole chiave.
uno studente può candidare più progetti?
Sì, ma si deve compilare un form per ogni elaborato associato ad una parola chiave.
CHE FORMATI SONO ACCETTATI?
Accettiamo .jpeg per le immagini (max 5MB) e per le poesie potete inviare un documento word.
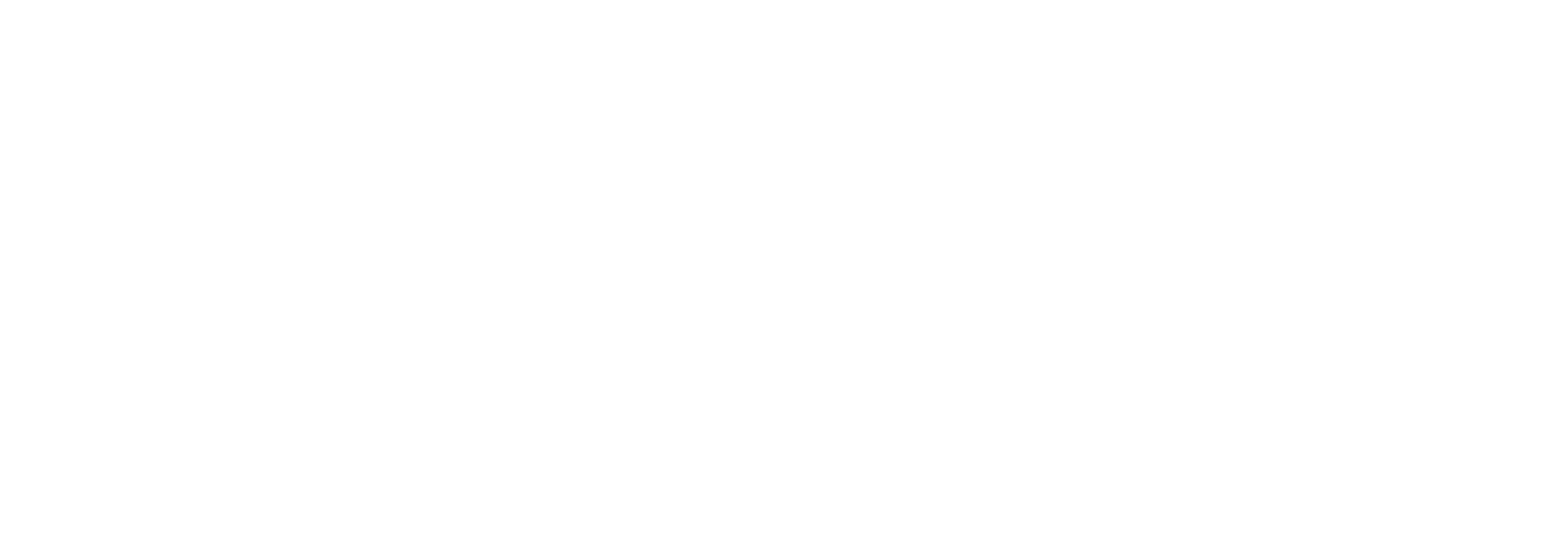
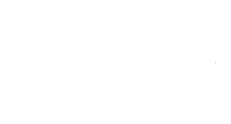

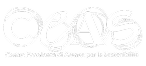
Emozionario Ambientale® è finanziato dalla Regione Puglia, curato e prodotto dal Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in partenariato con l’ideatore, l’APS Everything is Connected.
Acqua Virtuale
L’acqua virtuale è l’acqua che viene utilizzata per produrre beni e servizi, come ad esempio cibo, tessili, energia, ecc. L’acqua dolce è essenziale per la vita, ma nonostante la quantità di acqua sul pianeta resti fissa, con la crescita della popolazione mondiale aumenta il suo consumo totale e la sua disponibilità. Questo concetto tiene conto dell’acqua che viene utilizzata in tutti i passaggi della produzione, dalla coltivazione delle materie prime alla lavorazione e al trasporto.
L’acqua virtuale è importante per due motivi principali:
- Conservazione dell’acqua: comprendere l’acqua virtuale può aiutare a ridurre lo spreco di acqua e a promuovere pratiche di conservazione più efficaci.
- Sviluppo sostenibile: l’acqua virtuale può aiutare a valutare l’impatto ambientale dei beni e servizi e a promuovere scelte più sostenibili.
L’acqua virtuale spesso non viene vista dall’utente finale di un prodotto o servizio, ma quell’acqua è stata consumata lungo tutta la catena del valore, il che rende possibile la creazione di quel prodotto o servizio. Questo concetto ci permette di scoprire che consumiamo molta più acqua di quella che effettivamente vediamo scorrere davanti ai nostri occhi.
Il concetto di commercio di acqua virtuale è stato introdotto per fare riferimento all’idea che i paesi possono risparmiare acqua domestica importando cibo attraverso, appunto, il commercio internazionale di derrate alimentari, come frutta, verdura, ma anche servizi.
Il consumo di acqua è per la maggior parte effettuato dalla produzione agricola (74%) ma non solo: l’acqua viene utilizzata anche per la produzione di beni come abbigliamento, tecnologia e servizi nel settore industriale e il nostro consumo domestico, è una percentuale residua del consumo totale.
Facciamo un esempio:
Per preparare una ciotola di pasta, è necessaria acqua per far bollire la pasta secca nella pentola: questo è l’uso
diretto di acqua per la persona che mangia quella pasta a casa. Per produrre la pasta, è necessaria acqua in molti
passaggi lungo la catena del valore e quando l’acqua utilizzata in quei passaggi viene aggiunta, costituisce il
contenuto di acqua virtuale per quella pasta. Alcuni di questi passaggi includono: acqua per far crescere il grano;
acqua per produrre il carburante per le macchine per raccogliere il grano e trasportare la pasta al negozio; e acqua per
creare l’elettricità per trasformare il grano in farina e pasta.
Da dove proviene il cibo che mangiamo? In un mondo di risorse limitate, interrogarci sui nostri stili di vita e sui nostri modelli di consumo è necessario.
Gli impatti del cambiamento climatico hanno già portato a cambiamenti nel ciclo dell’acqua, causando periodi prolungati di siccità e, al contrario, precipitazioni più estreme in alcune aree. La riduzione delle scorte idriche potrebbe aumentare l’insicurezza anche geo-politica in molti paesi.
Agricoltura Intensiva
Questo termine ormai comune indica un metodo di coltivazione che mira a produrre quantità elevate di cibo in un’area limitata. L’agricoltura intensiva è un tipo di agricoltura che si propone di sfruttare al massimo la capacità produttiva del terreno attraverso la semina di più raccolti all’anno, la riduzione della frequenza degli anni di riposo del terreno, il miglioramento della tipologia di piante e l’agricoltura meccanizzata. In questo modo è possibile ottenere una maggiore resa e qualità dei prodotti e garantire una quantità di cibo sufficiente per la popolazione.
Nonostante, l’agricoltura intensiva abbia dei vantaggi, ci sono anche delle problematiche legate al loro uso:
- Impatto ambientale: l’agricoltura intensiva può avere un impatto negativo sull’ambiente, come la contaminazione dell’acqua e del suolo, quindi rischi sulla salute dell’uomo e degli animali
- Perdita di biodiversità: poiché vengono coltivate solo poche varietà di piante, questo impoverisce il terreno. Per esempio: le monocolture intensive, tipo o mais, occupano oltre l’80% dei terreni agricoli mondiali e arabili. E questo non soltanto per soddisfare la richiesta di cibo da parte della popolazione, ma anche per assicurare la quantità adeguata di mangimi per gli allevamenti intensivi.
La Comunità Europea si sta impegnando in maniera significativa per il futuro del sistema agricolo e alimentare e ha promosso un pacchetto di azioni strategiche nell’ambito del pilastro “Risorse naturali” del Green Deal, come indicato nell’obiettivo 2 dell’agenda 20230. È fondamentale trovare un equilibrio tra la produzione di cibo e la protezione dell’ambiente.
Allevamento Intensivo
Un allevamento intensivo è un tipo di allevamento in cui gli **animali vengono tenuti in spazi ristretti e controllati **, con l’obiettivo di produrre grandi quantità di carne, pesce, latte o uova.
Questo tipo di allevamento è diffuso sia sulla terraferma che nei mari e mira a soddisfare la crescente domanda globale di carne, pesce, latticini e altri prodotti animali, alimentata dall’incremento della popolazione umana. Gli animali, negli allevamenti terrestri, sono tenuti in recinti o capannoni chiusi, mentre quelli in mare vengono allevati in vasche o gabbie in acqua.
Secondo la FAO (Organizzazione Mondiale del cibo e dell’agricoltura), la domanda di prodotti di origine animale è * destinata ad aumentare significativamente entro il 2050*, con una crescita stimata del 70% nella richiesta globale di carne, pesce e prodotti lattiero-caseari.
Quali caratteristiche hanno gli allevamenti intensivi:
- Spazi ristretti: gli animali vengono tenuti in spazi piccoli e controllati.
- Alimentazione controllata: gli animali vengono alimentati con una dieta controllata e standardizzata.
- Uso di tecnologie avanzate: questo tipo di allevamenti utilizza tecnologie avanzate come sistemi di ventilazione e illuminazione controllata.
Svantaggi degli allevamenti intensivi:
- Condizioni di vita degli animali: gli animali negli allevamenti intensivi possono vivere in condizioni di stress e sofferenza.
- Impatto ambientale: questi allevamenti hanno un impatto negativo sull’ambiente, come l’inquinamento dell’aria e dell’acqua.
- Rischi per la salute dei consumatori: gli allevamenti intensivi possono aumentare il rischio di malattie trasmesse dagli animali agli esseri umani. Si registrano inoltre, dati allarmanti di aumento di malattie cardiovascolari, diabete e obesità.
- Gli allevamenti intensivi contribuiscono alla deforestazione massiccia in aree come l’Amazzonia, dovuta all’espansione delle colture di soia e dei pascoli per il bestiame.
- L’impatto idrico: è stato stimato che la produzione di un chilo di carne bovina può richiedere fino a 15.000 litri d’acqua.
Biodiversità
La biodiversità è la varietà di vita sulla Terra, che include tutte le specie di piante, animali, funghi e microorganismi che vivono in un ecosistema.
Il termine fu coniato dallo scienziato Edward O. Wilson nel 1988, associando il concetto alla ricchezza delle forme di vita, espressa in termini di abbondanza e variabilità nello spazio e nel tempo.
Qual è l’importanza della biodiversità?
- Regolazione del clima: gli ecosistemi aiutano a regolare il clima e a mantenere l’equilibrio dell’atmosfera.
- Produzione di cibo: la biodiversità è fondamentale per la produzione di cibo, dato che molte piante e animali sono utilizzati per l’alimentazione.
- Medicina e salute: la biodiversità è fonte di molte sostanze utilizzate in medicina e per la salute.
A quali sono le cause della minaccia e della perdita della biodiversità?
- Deforestazione: l’abbattimento e distruzione aggressiva delle foreste per far posto all’agricoltura intensiva,
- Urbanizzazione di massa e altre attività umane che alterano il normale ritmo della natura,
- Inquinamento: si parla sempre più spesso dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo che danneggiano gli ecosistemi e le specie che vi abitano all’interno.
- Cambiamenti climatici: i cambiamenti climatici possono alterare gli ecosistemi e le condizioni di vita delle specie.
Quali sono le misure per proteggere la biodiversità?
- Ridurre, riutilizzare, riciclare: ridurre il consumo di risorse, riutilizzare gli oggetti e riciclare i materiali.
- Proteggere gli ecosistemi: proteggere le foreste, gli oceani e gli altri ecosistemi da cui dipende la biodiversità.
- Sostenere le pratiche agricole sostenibili: attuare le pratiche agricole che rispettano la biodiversità e l’ambiente.
Più la diversità delle specie è alta, maggiore sarà la capacità dell’ecosistema di resistere o recuperare, rispetto alle perturbazioni o ad eventi dannosi. Un’alta biodiversità rafforza la stabilità di tutti i servizi dell’ecosistema, come la produzione di cibo, la regolazione del clima, la purificazione delle acque, e molto altro.
Blue Economy
L’economia blu è un modello economico che si basa sullo sviluppo sostenibile e sulla protezione dell’ambiente, in modo particolare pone l’attenzione sugli ambienti acquatici, mari, oceani e sulle risorse marine. I settori in cui si applica la blue economy comprendono: la pesca, l’acquacoltura, il trasporto marittimo, il turismo costiero, le energie rinnovabili, l’estrazione mineraria dei fondali marini e la biotecnologia marina. Questi settori sono interconnessi e la loro gestione sostenibile è fondamentale per mantenere la salute degli ecosistemi marini.
I principali problemi con l’economia blu:
- Capitalismo e sfruttamento delle risorse: l’economia blu spesso rispecchia i modelli capitalistici, dando priorità ai guadagni economici rispetto alla sostenibilità ambientale e sociale. Questo può portare allo sfruttamento delle risorse marine. Ad esempio, l’industrializzazione degli spazi oceanici attraverso attività come la trivellazione petrolifera offshore, l’estrazione mineraria in acque profonde, la pesca su larga scala e la costruzione di porti mirano a far crescere la ricchezza, ma rischiano lo sfruttamento eccessivo e l’esaurimento delle risorse.
- Separazione di terra e mare: i modelli economici tradizionali spesso trattano la terra e il mare come entità separate, non considerando l’interconnessione degli ecosistemi terrestri e marini. Questa separazione può portare a politiche che non tengono conto della natura interconnessa degli ecosistemi, influenzando la salute e la sostenibilità.
- Ingiustizie ambientali e sociali: l’economia blu può talvolta peggiorare le ingiustizie sociali e ambientali. Questioni come la pesca illegale, l’inquinamento, la distruzione degli habitat e il cambiamento climatico sono sfide molto importanti.
Tra gli obiettivi più importanti dell’economia blu c’è:
- Protezione dell’ambiente: protegge gli ecosistemi marini e le risorse naturali.
- Sviluppo sostenibile: promuove lo sviluppo economico in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.
- Creazione di opportunità: crea opportunità di lavoro e di sviluppo economico per le comunità che vivono sulla costa.
Dove opera l’economia blu?
- Pesca sostenibile: promuove la pesca sostenibile e la gestione delle risorse ittiche.
- Turismo marino: promuove il turismo marino sostenibile e responsabile.
- Energia rinnovabile: promuove l’uso di energie rinnovabili come l’energia eolica (energia che sfrutta il vento) e l’energia solare.
Tutti noi possiamo dare il nostro contributo, supporto come ridurre l’uso della plastica e di altri materiali che possono danneggiare l’ambiente marino, sostenere la pesca sostenibile e la gestione delle risorse ittiche; promuovere il turismo marino sostenibile e responsabile.
Cambiamento Climatico
Il cambiamento climatico è la variazione dello stato del clima terrestre nel tempo. Il cambiamento del clima può essere indotto da diverse cause sia naturali sia antropiche, cioè indotte dall’uomo. A partire dalla rivoluzione industriale, l’azione dell’uomo con le sue attività di emissione di gas serra ha contribuito fortemente al cambiamento climatico determinando un progressivo riscaldamento dell’atmosfera.
Le cause del cambiamento climatico sono diverse ma le principali sono le emissioni di gas serra nell’atmosfera, che comportano l’utilizzo in eccesso di combustibili fossili come il carbone, il petrolio e il gas naturale. Un altro fattore principale del cambiamento climatico sono le deforestazioni, ovvero la distruzione delle foreste per far posto all’agricoltura e all’urbanizzazione che riduce la capacità della Terra di assorbire il carbonio; l’agricoltura intensiva e l’uso di fertilizzanti e pesticidi influiscono al rilascio di gas serra.
Quali sono gli effetti del gas serra?
- Riscaldamento globale: l’aumento della temperatura media globale può causare ondate di calore, siccità e incendi boschivi.
- Cambiamenti nel clima: il cambiamento climatico può causare cambiamenti nei modelli climatici, come ad esempio piogge più intense e più frequenti.
- Innalzamento del livello del mare: lo scioglimento dei ghiacciai e dell’Antartide sta causando l’innalzamento del livello del mare.
- Perdita di biodiversità: aumento delle temperature, modifica delle precipitazioni, perdita di habitat, carenza idrica, perdita di raccolti, desertificazione, acidificazione degli oceani o incremento degli eventi atmosferici estremi, mettono sotto pressione gli ecosistemi locali, le piante e gli animali che li abitano.
A tutto ciò le popolazioni mondiali possono provare ad arginare le conseguenze catastrofiche del cambiamento climatico, in diversi modI:
- ridurre l’uso di combustibili fossili e usare mezzi di trasporto più efficienti e rinnovabili, come le biciclette o i veicoli elettrici,
- aumentare l’efficienza energetica attraverso l’uso di lampadine a basso consumo e apparecchi elettrici efficienti;
- proteggere le foreste e piantare alberi che assorbono il carbonio in eccesso;
- ridurre il consumo della plastica, riutilizzare gli oggetti e riciclare i materiali.
Capitalismo
Il capitalismo è un sistema economico e sociale in cui i mezzi di produzione e distribuzione dei beni e dei servizi
sono per lo più di proprietà privata e gestiti da individui o aziende per il raggiungimento del profitto. Questa
gestione privata del capitale vede persone e aziende possedere e gestire le risorse economiche, come le fabbriche, le
terre e il denaro.
Questo modello prevede che le persone e le aziende posseggano e gestiscano le risorse economiche, la libera concorrenza
in cui le aziende possono competere tra loro per vendere i loro prodotti e servizi, il profitto in cui le aziende
possono guadagnare denaro vendendo i loro prodotti e servizi ed infine nel capitalismo è presente il concetto di
mercato. Il mercato è il luogo in cui le aziende e le persone possono comprare e vendere i prodotti e servizi.
Tra i vantaggi del capitalismo:
- spiccato incentivo all’innovazione,
- efficienza nei servizi, nella distribuzione dei prodotti
- maggiore efficienza nella produzione
- maggiore scelta di prodotti e servizi.
Gli svantaggi del capitalismo sono:
- la disuguaglianza,
- lo sfruttamento
- l’instabilità che porta a crisi economiche
- diverse criticità quando viene valutato in relazione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Il capitalismo tradizionale si basa su un modello di crescita economica continua, spesso senza considerare i limiti fisici e biologici del pianeta. La ricerca incessante del profitto e l’accumulazione di capitale portano a un consumo eccessivo delle risorse naturali e alla degradazione dell’ambiente. Questo modello ha contribuito in modo significativo ai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità, all’inquinamento e al degrado degli ecosistemi.
Inoltre, le aziende, nel loro sforzo di ridurre i costi e massimizzare i profitti, spesso esternalizzano i costi ambientali, scaricandoli sulla società sotto forma di inquinamento o sfruttamento delle risorse. Questo fenomeno, noto come “tragedia dei beni comuni”, è un esempio di come il capitalismo può fallire nel proteggere i beni ambientali di uso comune, come l’aria, l’acqua e il suolo.
Dal punto di vista sociale, il capitalismo ha contribuito a una crescente disuguaglianza economica e sociale. La concentrazione della ricchezza e del potere nelle mani di un ristretto numero di individui e aziende può portare a un * aumento delle disparità tra ricchi e poveri,* sia a livello nazionale che globale. Il capitalismo tende a privilegiare il profitto rispetto al benessere dei lavoratori. La competizione globale può spingere le aziende a ridurre i costi del lavoro, spesso a scapito dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro. Questo è particolarmente evidente nei paesi in via di sviluppo, dove le normative sul lavoro sono meno rigide e i lavoratori sono più vulnerabili allo sfruttamento. In tal senso, si evince anche un legame tra capitalismo e patriarcato.
Uno dei principali modi in cui il capitalismo è legato al patriarcato è attraverso la divisione del lavoro basata sul genere. Rispetto alla sostenibilità sociale, il capitalismo spesso sfrutta la manodopera femminile a basso costo, sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. Le donne sono spesso impiegate in settori caratterizzati da salari bassi e scarse tutele lavorative, come il settore tessile, il lavoro domestico e il lavoro di cura.
Deforestazione
La deforestazione è la distruzione o la riduzione della copertura forestale, spesso a causa dell’attività umana. Tra le cause della deforestazione troviamo l’agricoltura intensiva, l’urbanizzazione eccessiva, l’industria del legno e l’estrazione di minerali o di altre risorse naturali che può portare a questa soluzione.
Perchè le foreste sono importanti?
- Sono custodi dell’80% della biodiversità con alberi, piante, insetti, uccelli e funghi che convivono in complessi ecosistemi
- le foreste coprono ⅓ della superficie terrestre globale. Metà di esse è ancora intatta e ⅓ è costituito da foreste primarie, preziosi scrigni di biodiversità senza tracce significative di attività umane
- le foreste sono la casa di milioni di persone, tra cui migliaia di popoli indigeni che da generazioni si battono per tutelare queste culle di biodiversità
- Le foreste, insieme agli oceani, rappresentano la nostra prima linea di difesa contro il cambiamento climatico e l’estinzione di numerose specie di piante e animali.
Le foreste assorbono ⅓ delle emissioni di CO2 causate dalla combustione di combustibili fossili (circa 2,6 miliardi di tonnellate), mentre la deforestazione rilascia gas serra nell’atmosfera contribuendo alla crisi climatica.
Quali sono i paesi maggiormente responsabili della deforestazione globale?
L’Unione Europea è il secondo maggiore importatore di deforestazione dopo la Cina. Tra il 2005 e il 2017, prodotti tra i
quali soia, olio di palma e carne di manzo sono state le materie prime con la maggiore deforestazione tropicale
incorporata importata nell’Unione Europea, seguite da prodotti del legno, cacao e caffè. Questi paesi sono:
Germania, Italia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Belgio e Polonia.
Desertificazione
La desertificazione è un processo di degradazione del suolo che determina una condizione di “sterilità” del terreno rendendo impossibile l’insediamento e lo sviluppo della flora e della fauna. Il processo di desertificazione viene associato alla scomparsa della copertura vegetale e alla perdita di funzioni dell’ecosistema della biodiversità e della capacità produttività biologica, quali foreste, pascoli, praterie. Tale processo è guidato sostanzialmente dalle condizioni ambientali e climatiche, ma può essere causato da eventi ed azioni umane che non gestiscono in maniera sostenibile il territorio, attraverso diverse forme di inquinamento.
I principali processi che determinano la degradazione del suolo possono essere legati all’alterazione del ciclo dell’acqua, con la conseguente siccità, alla salinizzazione del terreno dovuto all’intrusione di acque marine, ai processi di erosione, nonché agli incendi.
Gli effetti della desertificazione sono i seguenti:
1. Perdita di biodiversità: la desertificazione può portare alla perdita di specie vegetali e animali.
2. Riduzione della produzione agricola: la desertificazione può portare a una riduzione della produzione agricola.
3. Migrazione delle popolazioni: la desertificazione può portare alla migrazione delle popolazioni in cerca di terre più fertili.
4. Impatti economici: la desertificazione può avere impatti economici negativi sulle comunità locali.
Data la crescente emergenza in molte zone del mondo, alcune delle misure che potrebbero proteggere il suolo dalla desertificazione sono state identificate nei seguenti punti:
1. Agricoltura sostenibile: l’agricoltura sostenibile può aiutare a ridurre la desertificazione.
2. Rimboschimento: piantare alberi e ricostruire foreste
3. Conservazione dell’acqua: fare molta attenzione a non sprecare acqua
Ecosistema
Un ecosistema è un sistema composto da piante, animali, funghi e microorganismi che vivono insieme in un ambiente specifico, come una foresta, un oceano o un deserto. Un ecosistema è un’unità di organizzazione biologica che interagisce con l’ambiente fisico, e rappresenta un livello di organizzazione biologica che racchiude al suo interno gli organismi di diverse specie, le popolazioni e le comunità delle stesse. Come un organismo vivente nasce, cresce, raggiunge una maturità e poi muore; anche un ecosistema può essere pensato allo stesso modo.
Tra i vari temi dell’ecologia ci si è focalizzati sullo studio delle funzioni dei diversi ecosistemi presenti sul pianeta e al collegamento esistente tra ogni funzione e un determinato servizio utilizzato per le attività della società umana.
Si classificano tre tipi di servizi ecosistemici:
- servizi di regolazione, che interessano i gas atmosferici e quindi la stabilità del clima, i processi del suolo che controllano l’erosione, la prevenzione del dissesto idrogeologico, ma anche aspetti biologici, come l’impollinazione e il mantenimento della biodiversità;
- servizi di approvvigionamento, che permettono la produzione di cibo, materie prime, acqua dolce;
- servizi culturali, quali valori estetici, ricreativi, educativi, spirituali, artistici, identitari, che supportano il settore del turismo
L’insieme di questi servizi, si potrebbe semplificare come il capitale naturale. La complessità ecosistemica richiede metodologie e unità di misura ecologiche per quantificare questo valore che si basa sulle caratteristiche dell’energia che attraversa l’ecosistema e gli aspetti biofisici che determina la formazione del capitale naturale.
Funzionamento di un ecosistema
1. Ciclo dei nutrienti: i nutrienti vengono assorbiti dagli organismi e poi rilasciati nell’ambiente.
2. Ciclo dell’acqua: l’acqua viene assorbita dagli organismi e poi rilasciata nell’ambiente.
3.Catena alimentare: gli organismi si nutrono gli uni degli altri, formando una catena alimentare.
Quanto sono importanti gli ecosistemi?
1. Regolazione del clima: gli ecosistemi aiutano a regolare il clima.
2. Produzione di ossigeno: gli ecosistemi producono ossigeno.
3. Fornitura di risorse: gli ecosistemi forniscono risorse come cibo, acqua e legno.
Chi e cosa minaccia gli ecosistemi?
1. Deforestazione: la distruzione delle foreste.
2. Inquinamento: l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
3. Cambiamenti climatici: i cambiamenti climatici possono alterare gli ecosistemi.
Emissioni
Un’emissione è il rilascio di sostanze nocive nell’ambiente, come nell’aria, nell’acqua o nel suolo. Negli ultimi decenni, il termine emissione è comunemente associato a quello dei gas serra e, in particolare, si parla di emissioni di anidride carbonica (diossido di carbonio, o anidride carbonica o CO2) nel contesto dei cambiamenti climatici e delle alterazioni del clima. Infatti, i gas serra sono particolari gas di origine naturale che hanno la capacità di trattenere il calore riflesso e disperso dalla terra verso lo spazio all’interno dell’atmosfera.
Tra i diversi gas serra, sicuramente la CO2 è il gas più importante per quantità e regolazione della temperatura terrestre. La CO2 si produce all’interno di processi naturali biologici, come la respirazione cellulare, o nei processi di decomposizione e combustione della sostanza organica e, pertanto, può essere introdotto nell’atmosfera attraverso le attività umane, come l’agricoltura e l’allevamento, i trasporti, il riscaldamento delle case e l’industria.
Non meno rilevanti sono gli effetti diretti delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera che determinano l’acidificazione degli oceani. Questo fenomeno dipende dal fatto che gli oceani assorbono i gas, tra i quali la CO2, per una percentuale del 25% di quella contenuta in atmosfera.
I diversi tipi di emissioni sono:
1. Emissioni di gas serra: come il carbonio, il metano e l’ossido di azoto, che contribuiscono al riscaldamento globale.
2. Emissioni di inquinanti atmosferici: come il particolato, l’ozono e il biossido di azoto, che possono causare problemi respiratori.
3. Emissioni di sostanze chimiche: come i pesticidi e i prodotti chimici industriali, che possono contaminare l’acqua e il suolo.
Le attività umane che contribuiscono maggiormente a rilasciare emissioni sono:
1. Trasporti: le auto, i camion e gli aerei emettono gas serra e inquinanti atmosferici.
2. Industria: le fabbriche e le centrali elettriche emettono gas serra e inquinanti atmosferici.
3. Agricoltura: l’agricoltura può emettere gas serra e sostanze chimiche.
4. Rifiuti: la gestione dei rifiuti può emettere gas serra e inquinanti atmosferici.
Gli effetti delle emissioni si possono riassumere così:
1. Riscaldamento globale: le emissioni di gas serra contribuiscono al riscaldamento globale.
2. Inquinamento dell’aria: le emissioni di inquinanti atmosferici possono causare problemi respiratori.
3. Contaminazione dell’acqua e del suolo: le emissioni di sostanze chimiche possono contaminare l’acqua e il suolo.
Fast Fashion
La fast fashion è un modello di produzione e consumo di abbigliamento che si concentra sulla velocità e sulla
quantità, piuttosto che sulla qualità e sulla sostenibilità.
Con la fast fashion prodotti nuovi arrivano nei negozi anche con frequenza settimanale. Questo è diventato un comparto
di grande vitalità da un punto di vista economico.
La ragione del suo successo è la velocità dei tempi di realizzazione di un trend di moda: l’idea è tradotta in modelli
che vengono portati in produzione e realizzati industrialmente in 15 giorni.
Caratteristiche della fast fashion:
1. Produzione rapida: gli abiti vengono prodotti in grandi quantità e in tempi molto rapidi.
2. Prezzi bassi: gli abiti sono molto economici, il che li rende accessibili a molti consumatori.
3. Stili sempre nuovi: le collezioni di abbigliamento vengono aggiornate costantemente, per
tenere il passo con le ultime tendenze.
Questo tipo di acquisti e di politica hanno senz’altro impatti negativi:
1. Inquinamento ambientale: la produzione di abbigliamento richiede grandi quantità di acqua, energia e materie
prime
2. Sfruttamento dei lavoratori: molti lavoratori nel settore della moda sono sfruttati, lavorando in condizioni
difficili e per salari molto bassi, che consentono di vendere i prodotti a prezzi bassi
3. Microplastiche: ogni anno entrano negli Oceani tra le 200mila e le 500mila tonnellate di microplastiche
provenienti dai prodotti tessili. Tra il 16% e il 35% sono rilasciate dai lavaggi.
3. Rifiuti: la fast fashion genera grandi quantità di rifiuti, poiché gli abiti vengono spesso gettati via dopo
essere stati indossati solo poche volte. E quelli non venduti, spesso finiscono in grandi discariche.
Cosa possiamo fare per ridurre gli impatti negativi della fast fashion?
1. Acquistare meno, ma meglio: invece di acquistare molti abiti economici, investire in pochi abiti di qualità.
2. Scegliere marche sostenibili: cercare marche che si impegnano a ridurre il loro impatto ambientale e a trattare
i lavoratori con dignità.
3. Riutilizzare, riciclare e scambiare: trovare modi creativi per riutilizzare e riciclare gli abiti vecchi, e
scambiare abiti con amici e parenti può essere divertente.
Giustizia Climatica
La giustizia climatica è il concetto che si concentra sulla distribuzione equa degli impatti del cambiamento climatico e delle risorse per affrontarlo. Questo concetto riconosce che gli impatti del cambiamento climatico non sono distribuiti equamente e che coloro che sono meno responsabili di aver causato il problema spesso ne sopportano il peso maggiore. La giustizia climatica si interseca con due principi chiave: la giustizia distributiva e la giustizia intergenerazionale. Si parla infatti di giustizia distributiva che implica l’equa distribuzione delle risorse e degli oneri all’interno della società**, giustizia intergenerazionale** quel tipo di giustizia che riguarda i diritti e le responsabilità che esistono tra le diverse generazioni e, del green deal europeo, introdotto dalla Commissione europea, è un piano globale volto a rendere l’Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. L’accordo include i principi della giustizia intergenerazionale concentrandosi sulla sostenibilità e sulla salute ambientale a lungo termine. Esso include anche misure per ridurre le emissioni di gas serra, promuovere le energie rinnovabili e proteggere la biodiversità.
I principi della giustizia climatica
1. Equità: garantire che le risorse e gli sforzi per affrontare il cambiamento climatico siano distribuiti in modo
equo.
2. Giustizia: riconoscere e affrontare le ingiustizie storiche e attuali legate al cambiamento climatico.
3. Partecipazione: coinvolgere le comunità e gli individui più vulnerabili nel processo decisionale sul cambiamento
climatico.
Perché la giustizia climatica è importante?
Il cambiamento climatico è una questione critica per i diritti umani. Tutti meritano il diritto di vivere con dignità, eppure la crisi climatica mette in pericolo vite, mezzi di sussistenza, lingue e culture. Aumenta i rischi di carenza di cibo e acqua, sposta le comunità e innesca conflitti. Le popolazioni vulnerabili, con risorse limitate per adattarsi, soffrono di più. Inoltre, la crisi climatica minaccia il diritto a una buona salute. L’aumento delle temperature, i frequenti eventi meteorologici estremi e l’inquinamento dell’aria e dell’acqua portano a gravi problemi di salute come stress da calore, epidemie, malnutrizione e traumi da disastri.
Anche i sistemi educativi ne risentono. Le alte temperature e le condizioni meteorologiche estreme possono danneggiare le infrastrutture, impedire ai genitori di mandare i figli a scuola e mettere a repentaglio il futuro delle giovani generazioni.
La giustizia climatica è un quadro essenziale per affrontare i molteplici effetti del cambiamento climatico. Concentrandosi sulla giustizia distributiva e intergenerazionale, le società possono lavorare verso politiche più eque che tengano conto delle esigenze delle generazioni presenti e future. Superare gli ostacoli al raggiungimento della giustizia climatica richiede trasparenza, inclusività e un sostegno sostanziale da parte delle organizzazioni internazionali e dei paesi sviluppati.
Green Economy
La green economy è un modello che “migliora il benessere umano e l’equità sociale, riducendo significativamente i rischi ambientali e le carenze ecologiche”. La green economy assicura basse emissioni di carbonio, un efficiente uso delle risorse e risulta essere socialmente inclusiva.
Caratteristiche della green economy:
1. Sostenibilità ambientale: la green economy si concentra sulla protezione dell’ambiente e sulla riduzione dell’
impatto ambientale.
2. Efficienza energetica: la green economy promuove l’uso di energie rinnovabili e l’efficienza energetica.
3. Riduzione dei rifiuti: la green economy promuove la riduzione dei rifiuti e il riciclo dei materiali.
4. Sviluppo sostenibile: la green economy si concentra sullo sviluppo sostenibile e sulla riduzione della povertà.
Settori chiave della green economy
1. Energie rinnovabili: come l’energia solare e eolica.
2. Efficienza energetica: come l’isolamento degli edifici e l’uso di apparecchi elettrici efficienti.
3. Trasporti sostenibili: come le auto elettriche e i mezzi di trasporto pubblico.
4. Agricoltura sostenibile: come l’agricoltura biologica e l’uso di pratiche agricole sostenibili.
Benefici della green economy
1. Riduzione dell’impatto ambientale: la green economy può ridurre l’impatto ambientale delle attività
economiche.
2. Creazione di posti di lavoro: la green economy può creare nuovi posti di lavoro nel settore delle energie
rinnovabili e dell’efficienza energetica.
3. Sviluppo sostenibile: la green economy può contribuire allo sviluppo sostenibile e alla riduzione della povertà.
Tuttavia, la gestione inefficiente delle risorse naturali e la mancanza di una gestione sostenibile degli ecosistemi riduce la capacità degli stessi di fornire servizi ecologici cruciali, come la purificazione dell’acqua e la regolazione del clima. Le nuove generazioni erediteranno un ambiente meno resiliente e meno capace di sostenere la vita in equilibrio. È evidente che c’è bisogno di integrare le competenze in campo green economy nei sistemi educativi e offrire maggiori opportunità di formazione. Le politiche dovrebbero incentivare l’accesso a finanziamenti, prestiti e sovvenzioni per avviare iniziative green. Le nuove generazioni devono affrontare le conseguenze di politiche poco chiare e frammentate, e potrebbero trovarsi a dover migliorare le politiche esistenti.
Greenwashing
Il greenwashing è una pratica commerciale in cui un’azienda presenta se stessa come ecologica e sostenibile, anche se
in realtà non lo è. Il greenwashing è una strategia di marketing ingannevole utilizzata da alcune aziende per
presentarsi come ambientalmente responsabili, senza adottare azioni concrete per ridurre il loro impatto negativo
sull’ambiente.
Il termine “greenwashing” è stato coniato negli anni ‘80 dal saggista e attivista ambientale Jay Westerveld. La sua
critica nacque osservando un cartello in un hotel che incoraggiava i clienti a riutilizzare gli asciugamani per “salvare
il pianeta”. Westerveld ha usato il termine per descrivere questa apparente discrepanza tra il messaggio ecologico e
l’assenza di azioni concrete.
Perché le aziende fanno greenwashing?
1. Per migliorare la propria immagine: le aziende possono utilizzare il greenwashing per migliorare la propria
immagine pubblica e aumentare la fiducia dei consumatori.
2. Per aumentare le vendite: le aziende possono utilizzare il greenwashing per aumentare le vendite dei propri
prodotti, facendo credere ai consumatori che siano più ecologici.
3. Per evitare le critiche: le aziende possono utilizzare il greenwashing per evitare le critiche dei consumatori e
degli attivisti ambientali.
Esempi tipici di greenwashing includono l’uso di confezioni “verdi”, la promozione di prodotti con piccole modifiche ecologiche ma che mantengono pratiche di produzione insostenibili o la partecipazione a programmi di piantumazione di alberi come strategia di compensazione delle emissioni di CO2, senza ridurre realmente le emissioni.
I rischi del greenwashing per le nuove generazioni sono molteplici:
- Ritardo e ostacolo verso la transizione ecologica, che permettono quindi ai principali emettitori di continuare a produrre in maniera non ecologica ed evitando di fatto l’adeguamento ai limiti di emissioni
- Sottrazione di risorse pubbliche e private dedicate alla finanza climatica a favore di iniziative con minimo o nullo impatto positivo ambientale
- Disinformazione e difficoltà di reperire informazioni per l’educazione e l’attuazione di un consumo responsabile e di movimenti collettivi di partecipazione civile alla soluzione della crisi climatica.
- Minore impatto verso la riduzione dell’impronta dell’uomo, nei processi economici e industriali a favore di un semplice ma costoso strumento di comunicazione marketing ingannevole
- Perdita della fiducia da parte della comunità nelle pratiche di sostenibilità correttamente adottate e comunicate e progressiva inefficacia delle stesse
Impronta Ecologica
L’impronta ecologica è la misura dell’impatto ambientale di un individuo, di una comunità o di un’azienda sull’ ambiente. L’Impronta Ecologica è un indicatore che serve a misurare il consumo delle risorse biologiche operato dall’uomo in un anno al fine di sostenere le sue attività economiche e sociali.
Il termine impronta è stato adottato in senso metaforico dai suoi autori, al fine di associare il consumo delle risorse all’idea del segno lasciato dalla nostra società sul pianeta per un certo periodo di tempo.
L’impronta ecologica si calcola considerando i seguenti fattori:
1. Consumo di energia: quanto energia viene consumata per soddisfare le nostre esigenze.
2. Consumo di acqua: quanto acqua viene consumata per soddisfare le nostre esigenze.
3. Produzione di rifiuti: quanti rifiuti vengono prodotti dalle nostre attività.
4. Uso del suolo: quanto suolo viene utilizzato per soddisfare le nostre esigenze.
La sommatoria di tutte le impronte restituisce l’impronta ecologica globale che per comodità viene espressa in “numero di terre” consumate dalla popolazione globale. Per fare un esempio pratico, all’inizio degli anni ’60, le risorse sufficienti a soddisfare le richieste del consumo umano erano prodotte dai ¾ della superficie della terra. Dal 1970, la quantità di risorse richieste impegnava la biocapacità di tutta la terra. Ai giorni nostri, per soddisfare il consumo dell’uomo è necessaria una superficie superiore a quella di una terra e mezza.
Il concetto di impronta ecologica mette in evidenza come ci sia una stretta relazione tra il consumo delle risorse, il modello di sviluppo economico di un paese, nonché lo stile di vita che adottiamo nel quotidiano.
Tra le azioni che possiamo implementare per ridurre l’impronta ecologica?
1. Ridurre il consumo di energia: utilizzare energie rinnovabili e ridurre il consumo di energia elettrica.
2. Ridurre il consumo di acqua: utilizzare acqua risparmio e ridurre lo spreco di acqua.
3. Ridurre la produzione di rifiuti: riciclare e ridurre la produzione di rifiuti.
4. Utilizzare il trasporto pubblico o la bicicletta: ridurre l’uso dell’automobile e utilizzare mezzi di trasporto più ecologici.
Inquinamento
L’inquinamento è la presenza di sostanze dannose nell’ambiente che possono nuocere alla salute degli esseri viventi e all’ecosistema. Per inquinamento s’intende l’introduzione nell’ambiente di qualsiasi forma di energia, sostanze o materiali in grado di alterare l’equilibrio e il funzionamento dei sistemi naturali.
La sorgente di un inquinamento ambientale può essere rappresentata da:
- fenomeni naturali: per esempio fenomeni improvvisi come le eruzioni vulcaniche che rilasciano velocemente grandi quantità di gas tossici in atmosfera, oppure eventi su lunga scala temporale come la radioattività emessa dalle rocce.
- fenomeni legati alle attività umane: questi sono legati principalmente al rilascio di sostanze chimiche, di energie, di materiali o di elementi biologici che determinano danni ambientali e delle persone che vivono in determinate aree. A seconda delle attività umane possiamo individuare tipologie di inquinamento che impattano differentemente il suolo, l’acqua o l’aria.
Per capire alcuni esempi di inquinamento legato alle attività umane ci sono:
- Lo sversamento di sostanze tossiche e rifiuti nel suolo è un inquinamento che colpisce le produzioni agricole e gli allevamenti, determinando il rischio di avvelenamenti e impatti sulla salute umana tramite la catena alimentare
- questi sversamenti possono contaminare le falde acquifere e quindi propagare gli effetti negativi anche in aree lontane rispetto a quelle in cui si è verificato il primo inquinamento.
- Con l’avanzare del cambiamento climatico e la globalizzazione dei trasporti si sono aumentati gli inquinamenti di tipo biologico, rappresentati dall’introduzione di specie non autoctone, dette spesso specie aliene, che rappresentano una forte minaccia alla biodiversità locale e alle attività umane sia terrestri che marine.
Il problema dell’inquinamento dell’ambiente è spesso messo in secondo piano rispetto alla produzione di profitti economici secondo i principi del modello capitalistico. Tutti i prodotti di scarto dei processi industriali sono stati per tanto tempo trattati come rifiuti esterni e costi scaricati sull’ambiente e sulle popolazioni presenti in una determinata area. Questo modello ha determinato profonde crisi ambientali in diverse aree della terra con l’aumento della concentrazione di sostanze tossiche e di malattie, rendendo inabitabili e improduttivi molti territori.
Effetti dell’inquinamento
1. Problemi di salute: malattie respiratorie, problemi digestivi, tumori.
2. Danni all’ecosistema: distruzione di habitat, estinzione di specie.
3. Impatti economici: costi per la salute, perdita di produttività dei luoghi in cui l’inquinamento è alto.
Intelligenza Artificiale
L’intelligenza artificiale (IA) è una tecnologia che permette alle macchine di imparare, ragionare e prendere decisioni in modo autonomo, in modo simile all’intelligenza umana.
Tra i vantaggi dell’intelligenza artificiale troviamo i seguenti:
1. Efficienza: IA può eseguire compiti più velocemente e con maggiore precisione degli esseri umani.
2. Automatizzazione: IA può automatizzare compiti ripetitivi.
3. Innovazione: IA può aiutare a creare nuove tecnologie e prodotti, inclusi quelli legati alla ricerca medica.
Ma, l’IA e la digitalizzazione hanno un impatto significativo sull’ambiente a causa del consumo energetico associato ai centri dati, agli algoritmi di machine learning e alle reti neurali profonde, portando a un aumento del consumo di energia e, di conseguenza, delle emissioni di CO2. Vediamo in che modo:
- Centri dati: Le infrastrutture che ospitano i server per l’elaborazione e la memorizzazione dei dati consumano una quantità crescente di energia. Secondo alcune stime, i centri dati sono responsabili di circa l’1-2% del consumo energetico globale e il loro impatto potrebbe crescere se non vengono adottate misure di efficienza energetica.
- Addestramento di modelli IA: Un singolo modello può richiedere enormi quantità di energia per essere addestrato. Soluzioni proposte includono l’uso di energia rinnovabile per alimentare i centri dati e lo sviluppo di modelli IA più efficienti dal punto di vista energetico
Tra gli altri problemi legati all’IA, cìè quello che potrebbe anche essere sfruttata per manipolare informazioni, amplificando la disinformazione su questioni cruciali come il cambiamento climatico. In che modo?
- Algoritmi dei social media: Le piattaforme digitali utilizzano l’IA per personalizzare i contenuti per gli utenti, ma questo può portare alla concentrazione delle opinioni e alla diffusione di notizie false e fuorvianti. .
- Deepfake e falsificazioni digitali: L’IA può essere utilizzata per creare contenuti falsificati difficili da distinguere dalla realtà. Questi strumenti possono essere impiegati per creare o diffondere notizie false su eventi legati al clima, alterando il dibattito pubblico e generando confusione su questioni ambientali critiche.
- Manipolazione delle percezioni: Le aziende e i governi possono usare l’IA per migliorare la propria immagine ambientale, un fenomeno che può essere collegato al greenwashing digitale, dove si esagerano i benefici delle loro azioni a favore dell’ambiente.
L’IA porta con sé ulteriori sfide e limiti:
1. Sicurezza: l’IA può essere utilizzata per scopi malevoli
2. Privacy: l’IA può raccogliere e utilizzare dati personali senza il consenso delle persone
3. Disoccupazione: l’IA potrebbe sostituire alcuni lavori che compiono gli esseri umani.
Una domanda che dovremmo porci è: cosa ci rende umani in un mondo gestito dall’Intelligenza artificiale?
Mobilità Sostenibile
La mobilità sostenibile è un modo di spostarsi che riduce l’impatto ambientale e migliora la salute e la qualità della
vita. Significa scegliere mezzi di trasporto che inquinano meno, come la bici, i mezzi pubblici o le auto elettriche.
L’obiettivo è spostarci in modo comodo ed efficiente, ma senza danneggiare il pianeta.
I veicoli a motore tradizionale, come auto e moto a benzina o diesel, rilasciano nell’aria sostanze inquinanti come
l’anidride carbonica (CO₂), gli ossidi di azoto (NO e NO2) e le polveri sottili come il particolato (PM10 e PM2.5).
Questi gas inquinano l’aria e possono causare problemi alla salute, soprattutto nelle città molto trafficate.
Oltre all’inquinamento, un altro problema centrale è la congestione del traffico. In molte città, il numero di veicoli privati in circolazione causa ingorghi che rallentano gli spostamenti e riducono la produttività. Il tempo perso nel traffico ha ripercussioni economiche significative, aumentando i costi del carburante e della manutenzione dei veicoli, oltre a ridurre il benessere dei cittadini a causa dello stress e della frustrazione legati ai ritardi.
Il consumo di suolo è un ulteriore problema legato alla mobilità tradizionale. Le città sono spesso progettate attorno all’uso dell’auto privata, con enormi spazi dedicati a strade, autostrade e parcheggi, sottraendo spazio a parchi, aree verdi e spazi pubblici. Questo modello urbano riduce la vivibilità delle città, rendendole meno accoglienti per pedoni e ciclisti, e contribuendo al fenomeno dell’isola di calore urbano, che aumenta le temperature nelle aree densamente cementificate.
Esempi di mobilità sostenibile:
1. Trasporto pubblico: autobus, treni, metropolitana.
2. Bicicletta
3. Piedi: camminare è un modo sostenibile e salutare di spostarsi.
4. Veicoli elettrici o ibridi: veicoli che utilizzano energia elettrica o combinano energia elettrica e benzina.
5. mobilità condivisa: come il car sharing e il bike sharing, che consentono di ridurre il numero di auto in
circolazione
Vantaggi della mobilità sostenibile:
1. Riduzione delle emissioni di gas serra
2. Miglioramento della qualità dell’aria
3. Miglioramento della salute
4. Riduzione del rumore
Oceano
L’oceano copre circa il 70% della superficie terrestre e contiene il 97% dell’acqua totale del nostro pianeta ed è fondamentale per regolare il clima e sostenere la vita. L’oceano è diviso in cinque bacini: Artico, Atlantico, Pacifico, Indiano e Sud.
Il cambiamento climatico indotto dall’uomo, guidato principalmente dalle emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di combustibili fossili, ha aumentato i livelli di CO2 atmosferica del 30% dall’inizio dell’ industrializzazione nel XIX secolo.
L’oceano e l’atmosfera mantengono un equilibrio; con l’aumento della CO2 atmosferica, l’oceano ne assorbe di più, questo processo funziona in modo più efficace nelle acque più fredde come i mari del Labrador, la Groenlandia e l’Antartide. Questo processo immagazzina CO2 per secoli. Tuttavia, l’assorbimento di CO2 nell’oceano non è illimitato e varia. Oltre ad assorbire CO2, l’oceano assorbe anche quasi tutto il calore aggiuntivo derivante dall’effetto serra. Questo calore nascosto modera l’aumento della temperatura superficiale, ma con delle conseguenze:
- acidificazione dell’oceano,
- innalzamento del livello del mare
- sconvolgimenti dell’ecosistema, tra cui lo sbiancamento dei coralli
L’oceano è importante per diversi motivi:
1. Regolazione del clima: gioca un ruolo fondamentale nella regolazione del clima terrestre.
2. Produzione di ossigeno: l’oceano produce circa il 50-85% dell’ossigeno che respiriamo.
3. Fonte di cibo: l’oceano è una fonte importante di cibo per molti paesi del mondo.
Cosa danneggia l’oceano:
1. Inquinamento: l’oceano è minacciato dall’inquinamento da plastica, petrolio e altre sostanze chimiche.
2. Sovrapesca: ovvero quando si pescano troppi pesci, più velocemente di quanto gli oceani riescano a farli riprodurre. Questa pratica sta minacciando la biodiversità marina.
3. Cambiamenti climatici: i cambiamenti climatici stanno influenzando la temperatura e il livello dell’oceano, generando diversi effetti dannosi sugli ecosistemi marini.
Quando la temperatura dell’oceano aumenta, l’equilibrio della vita marina viene messo in pericolo. Uno degli effetti più conosciuti è lo sbiancamento dei coralli.
Le barriere coralline, che sono come foreste colorate sotto il mare, sono molto sensibili ai cambiamenti di temperatura.
Quando l’acqua diventa troppo calda, i coralli “scacciano” delle alghe speciali che vivono dentro di loro. Queste alghe
non solo danno ai coralli i loro colori vivaci, ma li aiutano anche a nutrirsi grazie alla fotosintesi.
Senza di loro, i coralli diventano bianchi e deboli, e rischiano di morire.
Plastica
La plastica è un materiale sintetico ottenuto dalla lavorazione di sostanze chimiche come il petrolio e il gas
naturale. Questo materiale è composto da polimeri che possono essere modellati e plasmati in diverse forme.
Grazie alle sue proprietà come la leggerezza, la durabilità e la versatilità, la plastica è utilizzata in moltissimi
settori: imballaggio, elettronica, edilizia, sanità, automotive e molto altro. La produzione mondiale di plastica è
stimata ad oggi intorno ai 400 milioni di tonnellate. L’Italia è uno dei principali produttori, i cui principali usi
includono imballaggi (39,6%), edilizia (20,4%) e l’industria automobilistica (10%).
Tipi di plastica:
1. Plastica biodegradabile: può essere decomposta naturalmente dagli organismi viventi.
2. Plastica non biodegradabile: non può essere decomposta naturalmente e rimane nell’ambiente per centinaia di
anni.
Utilizzi della plastica:
1. Imballaggi: plastica utilizzata per imballare prodotti alimentari e non.
2. Oggetti di uso quotidiano: plastica utilizzata per creare oggetti come bottiglie, contenitori, sacchetti.
3. Tecnologia: plastica utilizzata in componenti elettronici e in altri prodotti tecnologici.
Impatti ambientali della plastica:
1. Inquinamento dei mari: la plastica spesso finisce nei mari, causando danni agli ecosistemi marini.
2. Inquinamento del suolo: la plastica può finire nel suolo e causare danni agli ecosistemi terrestri.
3. Consumo di risorse: la produzione di plastica richiede grandi quantità di risorse come petrolio e gas naturale.
L’inquinamento da plastica rappresenta una sfida importante per le generazioni future, infatti la plastica presente
oggi nell’ambiente, se non rimossa, continuerà a deteriorarsi in microplastiche, influenzando negativamente gli
ecosistemi e sulla salute umana, per secoli.
In risposta a questa crisi, molti giovani si stanno attivando per promuovere soluzioni sostenibili. Esistono
fortunatamente numerosi movimenti globali di giovani attivisti che chiedono una drastica riduzione dell’uso della
plastica monouso e un passaggio a sistemi di economia circolare, dove il riciclo e il riutilizzo sono prioritari
rispetto alla produzione di nuovi materiali plastici.
L’adozione di politiche più rigide, come ad esempio il divieto delle plastiche monouso in alcuni Paesi europei e
l’introduzione di sistemi per incoraggiare le persone a restituire oggetti usati e riciclabili, è essenziale per ridurre
l’impatto ambientale. Essendo un problema molto complesso, le soluzioni richiedono un approccio che coinvolga diverse
discipline e una collaborazione di tutti e tutte.
Povertà Alimentare
La povertà alimentare è la condizione in cui una persona o una famiglia non ha accesso a cibo sufficiente e nutrizionale per soddisfare le proprie esigenze. Questa definizione è opposta al concetto di food security, ovvero sicurezza alimentare. Secondo questo principio, tutte le persone hanno accesso fisico, economico e sociale ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti così da soddisfare le proprie necessità e preferenze alimentari, oltre che a godere di una vita sana e attiva.
Secondo l’Agenda 2030, Obiettivo 2, è necessario “porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile”.
La pandemia ha aumentato in maniera significativa il numero di poveri, anche in Italia. Il rapporto di Save the Children ha evidenziato che al 2023, 200 mila bambini tra 0 e 5 anni vivono in famiglie che non riescono a garantire un pasto proteico ogni 2 giorni e la maggior parte risiede nel Sud Italia e nelle isole. A questo si aggiunge il consumo di cibi ultra processati e a basso costo per compensare i deficit nutrizionali, ma con delle conseguenze sulla salute umana. I cosidetti “cibi ultraprocessati” sono alimenti confezionati e pronti per essere riscaldati o consumati direttamente, frutto di ripetute lavorazioni industriali. Tuttavia assumerne troppi può creare problemi per la salute e aumentare il rischio di tumore del colon anche del 30 per cento circa.
Una possibile soluzione per contrastare la povertà alimentare è combattere lo spreco alimentare.
Le cause della povertà alimentare possono essere trovate in:
1. Povertà economica: la mancanza di risorse economiche per acquistare cibo di buona qualità;
2. Disuguaglianza sociale e la discriminazione possono limitare l’accesso al cibo;
3. Cambiamenti climatici possono influire sulla produzione alimentare e sull’accesso al cibo;
4. Conflitti e crisi possono interrompere la produzione e la distribuzione del cibo.
Effetti della povertà alimentare:
1. la malnutrizione può causare problemi di salute e di sviluppo;
2. la mancanza di cibo può causare fatica e debolezza;
3. la povertà alimentare può aumentare il rischio di malattie e problemi di salute;
4. la povertà alimentare può influire sulla **capacità di apprendimento e di conseguenza sull’istruzione delle persone. **
Come combattere la povertà alimentare:
- Azioni di gestione e recupero delle eccedenze di cibo
- Sostenere le politiche di sicurezza alimentare e l’accesso al cibo
- Aiutare le organizzazioni umanitarie che lavorano per combattere la povertà alimentare
- Promuovere l’agricoltura sostenibile e la produzione di cibo locale
- Ridurre lo spreco di cibo e utilizzare le risorse alimentari in modo più efficiente.
Riciclo
Il riciclo è il processo di trasformazione dei materiali di scarto in nuovi prodotti, riducendo così la quantità di rifiuti e conservando le risorse naturali. Il riciclo è una pratica fondamentale per ridurre l’impatto ambientale della gestione dei rifiuti e per conservare risorse preziose; Tuttavia, gli esseri umani non stanno ancora sfruttando a pieno il riciclo. Molti materiali che potrebbero essere riciclati finiscono ancora in discarica o vengono inceneriti.
Materiali che possono essere riciclati:
Carta e cartone: giornali, scatole di cartone, carta da pacchi.
Plastica: bottiglie di plastica, contenitori di plastica, sacchetti di plastica.
Vetro: bottiglie di vetro, contenitori di vetro.
Metallo: lattine di alluminio, contenitori di acciaio.
Rifiuti organici: Scarti alimentari e vegetali che possono essere trasformati in compost.
Tessuti: Vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc.
Altro: Pneumatici, pile e accumulatori, CD e DVD, capsule in alluminio, alcuni oggetti in legno.
È difficile stabilire con precisione l’efficacia reale del riciclo, e i seguenti punti restano le sfide più grosse:
- il riciclo dei rifiuti plastici: grandi quantità di plastica continuano a essere disperse nell’ambiente o inviate in discariche, dove impiegano centinaia di anni per degradarsi.
- il riciclo inefficiente porta alla perdita di materiali preziosi come metalli rari, che potrebbero essere recuperati dai rifiuti elettronici, ma spesso non lo sono a causa della mancanza di tecnologie adeguate.
- il consumo di acqua nel processo di riciclo rappresenta uno dei problemi più grandi. Il riciclo, soprattutto di materiali come la carta e la plastica, richiede grandi quantità di acqua per la pulizia e la trasformazione dei materiali.
Sebbene il riciclo possa far risparmiare risorse, se non viene gestito in modo efficiente, può anche aumentare la pressione sulle risorse idriche, specialmente in aree già colpite da scarsità d’acqua. Un uso più sostenibile dell’acqua nel settore del riciclo è quindi fondamentale per ridurre l’impatto complessivo dell’industria sul pianeta.
Benefici del riciclo:
1. Riduzione dei rifiuti: il riciclo riduce la quantità di rifiuti che finiscono in discarica.
2. Conservazione delle risorse: il riciclo conserva le risorse naturali.
3. Riduzione delle emissioni di gas serra: il riciclo riduce le emissioni di gas serra.
4. Creazione di posti di lavoro: il riciclo crea posti di lavoro nell’industria del riciclo.
Rifiuto
Un rifiuto è un materiale o un oggetto che non è più utile o che non può essere riutilizzato. Il problema dei rifiuti sta diventando una questione sempre più critica, soprattutto per le giovani generazioni, che si troveranno ad affrontarne le conseguenze nel prossimo futuro. L’inquinamento da rifiuti minaccia la salute umana, costa all’economia globale centinaia di miliardi di dollari ogni anno e aggrava la tripla crisi planetaria: cambiamento climatico, perdita della natura e della biodiversità, e inquinamento.
I rifiuti che ci riguardano più da vicino sono:
- RIFIUTI ELETTRONICI: ogni anno milioni di tonnellate di dispositivi elettronici vengono gettati via. Questo porta a enormi accumuli di rifiuti elettronici, contenenti materiali preziosi come oro e rame, ma anche sostanze tossiche come mercurio e piombo
- RIFIUTI DI PLASTICA: Gli oggetti di uso quotidiano, come bottiglie, cannucce e sacchetti di plastica, sono alcuni degli esempi. Gran parte dei rifiuti plastici non viene riciclata e finisce per inquinare gli oceani, mettendo a rischio la vita marina e l’intero ecosistema, inclusa la salute umana
- RIFIUTI TESSILI: la Fast Fashion è responsabile del riversamento, ogni anno, di tonnellate di abiti che vengono gettati via. Questi spesso finiscono in discarica o incenerite, causando un’enorme pressione sulle risorse e sull’ ambiente
- SPRECO ALIMENTARE: Il 60% dello spreco alimentare avviene a livello domestico:una persona in media spreca79 kg di cibo all’anno, come se ogni giorno fosse buttato l’equivalente di un miliardo di pasti, un dato chein Italia sale a 107 kg all’anno. la perdita alimentare contribuisce al 10% delle emissioni di gas serra globali.
Tipi di rifiuti:
1. Rifiuti organici: rifiuti come cibo, frutta e verdura.
2. Rifiuti inorganici: rifiuti come plastica, vetro e metallo.
3. Rifiuti pericolosi: rifiuti come batterie, farmaci e sostanze chimiche.
Le maggiori problematiche legate ai rifiuti sono:
1. perdita di biodiversità, vuol direperdere una fonte di risorse naturali cruciali per le necessità e le attività umane, perdere principi naturali determinanti per la produzione di attuali e future medicine, perdere sistemi naturali di protezione dagli eventi estremi prodotti dai cambiamenti climatici
2. inquinamento: presenza di sostanze nocive nell’ambiente che possono avere un impatto negativo sulla fauna e sulla flora, sulla qualità dell’acqua, dell’aria e del suolo.
3. cambiamento climatico: si intendono i cambiamenti a lungo termine delle temperature e dei modelli meteorologici, principalmente causati dalle attività umane, imputabili alla combustione di combustibili fossili come il carbone, il petrolio e il gas. La combustione di combustibili fossili genera emissioni di gas a effetto serra che agiscono come una coltre avvolta intorno alla Terra, trattenendo il calore del sole e innalzando le temperature.
Tra le soluzioni a cui tutti possiamo partecipare ci sono:
1. Ridurre la quantità di rifiuti prodotti
2. Riutilizzare oggetti e materiali invece di gettarli via
3. Riciclare materiali come carta, plastica e vetro
4. Sostenere le politiche di gestione dei rifiuti e promuovere la responsabilità ambientale
Il problema dei rifiuti è una sfida complessa e in continua crescita, che colpisce tutte le generazioni, ma avrà un impatto particolarmente profondo sui giovani. Tuttavia, attraverso l’educazione, la tecnologia, e l’adozione di modelli di consumo più sostenibili, le nuove generazioni hanno la possibilità di trasformare questa crisi in un’opportunità per costruire un futuro più verde e giusto.
Rifugiati Climatici
Un rifugiato climatico è una persona che è costretta a lasciare la propria casa o comunità a causa degli impatti dei
cambiamenti climatici, come inondazioni, siccità, uragani o innalzamento del livello del mare.
Secondo recenti statistiche oltre 376 milioni di persone in tutto il mondo sono state costrette a spostarsi a causa
di inondazioni, tempeste di vento, terremoti o siccità dal 2008, con un record di 32,6 milioni solo nel 2022.
Cause della migrazione climatica:
1. Cambiamenti climatici come l’innalzamento del livello del mare, le inondazioni e le siccità.
2. Degradazione ambientale come la deforestazione e la perdita di biodiversità.
3. Conflitti per le risorse come l’acqua e la terra.
Effetti della migrazione climatica:
1. Impatti sociali: la migrazione climatica può causare la perdita di comunità e di identità culturale.
2. Impatti economici: la migrazione climatica può causare la perdita di mezzi di sussistenza e di opportunità
economiche.
3. Impatti ambientali: la migrazione climatica può causare la degradazione ambientale e la perdita di biodiversità.
Al momento non esiste una definizione chiara e ufficiale di “rifugiato climatico”, né i rifugiati climatici sono coperti dalla Convenzione sui rifugiati del 1951. Ciò significa che il clima non può attualmente essere citato come motivo per richiedere asilo o status di rifugiato.
Alcuni dei discorsi più recenti in tutto il mondo su come affrontare e concepire la migrazione climatica, vanno nella direzione di trasformare questo fenomeno in un movimento demografico umano epocale. Si prevede che il Sud del mondo aumenterà di numero di popolazioni e sarà principalmente colpito da eventi climatici e ambientali catastrofici, che porteranno i suoi abitanti a doversi spostare per sopravvivere. Il Nord del mondo affronta il problema opposto: una crisi demografica molto pesante, un aumento degli anziani che supera la percentuale di giovani lavoratori che pagano le pensioni, mettendo il sistema pensionistico sull’orlo del collasso. Quindi, se dovessimo cambiare la prospettiva e la percezione delle persone sulla migrazione climatica, da paura e problema a speranza e soluzione, possiamo pensare di immaginare questo argomento in una grande opportunità per tutti.
Siccità
La siccità è un periodo di tempo prolungato in cui una regione non riceve sufficiente pioggia o precipitazioni, causando una carenza di acqua. Per la prima volta un gruppo di studiosi ha mappato a livello globale il fenomeno delle megasiccita‘, fenomeni che colpiscono in maniera persistente una regione per più anni di seguito. Le siccità severe hanno già arrecato danni considerevoli in diverse aree del Pianeta e aumenteranno nel prossimo futuro in frequenza, severità ed estensione.
Si stima che entro il 2050 questo fenomeno potrebbe colpire più di tre quarti della popolazione mondiale, con più di cinque miliardi di persone che vivranno in aree con scarsità d’acqua per almeno un mese all’anno, rispetto ai 3,6 miliardi di oggi.
Tra le cause principali della siccità in Italia:
- Cambiamento climatico: L’aumento delle temperature e la riduzione delle precipitazioni invernali sono fattori chiave che contribuiscono alla siccità.
- Gestione inefficiente dell’acqua: La perdita di acqua in distribuzione, la mancanza di investimenti in infrastrutture idriche e la malagestione sono altri fattori che aggravano il problema.
- Agricoltura intensiva: L’uso eccessivo di acqua per l’irrigazione delle coltivazioni contribuisce al consumo di acqua.
- Spreco di acqua: Una diffusa cultura dello spreco di acqua, soprattutto in agricoltura, è un altro fattore che contribuisce alla siccità.
Secondo il WWF quello che possiamo fare come popolazione è:
- necessità di aumentare gli obiettivi di riduzione delle emissioni,
- portare avanti la transizione energetica
- adattarsi alle conseguenze dell’aumento delle temperature.
Senza impegni economici forti in questo senso le comunità vulnerabili saranno sempre più esposte agli impatti climatici devastanti e la possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C si perderà.
Stagionalità
La stagionalità è il cambiamento delle condizioni climatiche e ambientali che si verifica nel corso dell’anno,
solitamente diviso in quattro stagioni: primavera, estate, autunno e inverno.
Il concetto di stagionalità è spesso associato al consumo di frutta e verdura, ma anche a prodotti ittici.
Prima che la scienza inventasse nuovi metodi di coltivazione in agricoltura – vedi agricoltura intensiva - era
possibile trovare prodotti freschi solo nella stagione in cui crescevano meglio, poiché i prodotti dipendevano dal
clima e da altre condizioni naturali di crescita. Oggi, invece, è possibile trovare praticamente qualsiasi frutto o
verdura, indipendentemente dal periodo dell’anno.
L’alimentazione stagionale però può avere significati diversi a seconda delle diverse regioni del nostro Paese (e ancor
di più nei diversi Paesi del mondo).
Effetti della stagionalità:
1. Sull’ambiente: la stagionalità influenza la crescita delle piante, la migrazione degli animali e la formazione
dei paesaggi.
2. Sull’agricoltura: la stagionalità influenza la coltivazione e la raccolta di frutta e verdura.
3. Sulla società: la stagionalità influenza le attività umane, come il turismo, lo sport e le festività.
Importanza della stagionalità
1. Ciclo della vita: la stagionalità è essenziale per il ciclo di vita delle piante e degli animali.
2. Biodiversità: la stagionalità contribuisce alla biodiversità, poiché ogni stagione offre condizioni diverse per
la crescita e la sopravvivenza delle specie.
3. Economia: la stagionalità influenza l’economia, poiché le attività umane sono spesso legate alle stagioni.
Associato al concetto di stagionalità, c’è quello del km 0, ovvero ai prodotti alimentari che vengono coltivati o prodotti vicino a dove viviamo. Questo significa che non devono viaggiare per lunghe distanze per arrivare sulle nostre tavole.
In generale, fare la spesa a km 0 ha diversi vantaggi:
- Comporta una riduzione dei costi relativi a tutti i passaggi intermedi tra chi produce, acquista e consuma il prodotto.
- Garantisce numerosi vantaggi per l’ambiente: riduzione delle emissioni di CO2 liberata nell’aria dai fertilizzanti e dei trasporti; riduzione degli imballaggi di plastica o cartone; riduzione dello spreco di acqua ed energia per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti.
Terre Rare
Le Terre Rare (REEs - Rare Earth Elements) sono un gruppo di 17 elementi chimici con proprietà uniche e importanti
per molte applicazioni tecnologiche.
Le tecniche tradizionali di estrazione delle REEs sono altamente inquinanti, utilizzando acidi forti e altri
solventi chimici che contaminano il suolo e le acque, causando gravi danni agli ecosistemi locali e alle comunità umane
circostanti.
Utilizzi delle Terre Rare:
1. Tecnologia: le Terre Rare sono utilizzate in molti dispositivi elettronici, come smartphone e computer.
2. Energia: le Terre Rare sono utilizzate nelle tecnologie per l’energia rinnovabile, come le pale eoliche.
3. Trasporti: le Terre Rare sono utilizzate nei sistemi di navigazione e di controllo dei veicoli.
4. Medicina: le Terre Rare sono utilizzate in alcuni trattamenti medici, come la radioterapia.
Problemi legati all’utilizzo delle Terre Rare:
1. Estrazione: l’estrazione delle Terre Rare può avere impatti ambientali negativi.
2. Riciclaggio: il riciclaggio delle Terre Rare è difficile e costoso.
3. Dipendenza: la dipendenza dalle Terre Rare può creare problemi di sicurezza e di approvvigionamento.
Per le nuove generazioni, il problema delle terre rare è particolarmente rilevante. Da un lato, i giovani sono spesso tra i principali consumatori di dispositivi elettronici e sostenitori della transizione ecologica, dall’altro sono anche i futuri eredi di un pianeta che potrebbe soffrire gravemente delle conseguenze ambientali delle attuali pratiche di estrazione mineraria. Inoltre, la crescente domanda di terre rare potrebbe causare aumenti dei prezzi dei prodotti tecnologici e rallentare lo sviluppo delle energie rinnovabili, elementi fondamentali per affrontare la crisi climatica.
Tra le possibili soluzioni legate ai problemi dell’estrazione delle Terre Rare, c’è Il riciclo e l’adozione di
pratiche più sostenibili, come l’uso di tecnologie biotecnologiche (bioleaching, biosorbimento e bioprecipitato) per
il recupero delle terre rare dai rifiuti elettronici urbani, rappresentano una possibile soluzione per mitigare questo
problema. La sfida, tuttavia, è implementare queste tecnologie su larga scala in modo economicamente sostenibile e *
sviluppare una maggiore consapevolezza tra i consumatori*, specialmente le giovani generazioni, dell’impatto che le
terre rare hanno sull’ambiente.
Nonostante queste tecnologie abbiano già dimostrato il loro potenziale, la loro applicazione commerciale è ancora
limitata.
Transizione Ecologica
La transizione ecologica è il processo di cambiamento verso un modello di sviluppo più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Con questa espressione si intende il passaggio o la trasformazione da un sistema produttivo intensivo ( massimo utilizzo di risorse per una maggiore produttività) e non sostenibile dal punto di vista dell’impiego delle risorse, a un modello che invece ha nella sostenibilità, ambientale, sociale ed economica, il proprio punto di forza.
Perché è necessaria la transizione ecologica?
1. Cambiamenti climatici: per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.
2. Deperimento ambientale: per proteggere la biodiversità e prevenire la distruzione degli ecosistemi.
3. Esaurimento delle risorse: per gestire in modo più efficiente le risorse naturali e ridurre lo spreco.
La transizione ecologica si basa su diversi aspetti fondamentali, tra cui:
1. Energia rinnovabile: passare dalle fonti di energia fossile a quelle rinnovabili
2. Efficienza energetica: ridurre il consumo di energia e migliorare l’efficienza degli edifici e dei trasporti
3. Agricoltura sostenibile: promuovere pratiche agricole che rispettino l’ambiente e la biodiversità
4. Riduzione dei rifiuti: ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il riciclo e il riuso, caratteristiche
dell’economia circolare.
Sebbene la transizione ecologica porti con sé tanti vantaggi, presenta ancora diversi problemi per la sua attuazione. Tra i principali troviamo:
- povertà di risorse per la costruzione di impianti ecologici che rende l’italia (e molti altri Paesi) dipendente
dall’importazione (i materiali necessari alla costruzione di pale eoliche e impianti geotermici giungono da zone al di
fuori dell’Europa)
- costruzione e uso di impianti e strumenti ecologici comportano spesso un impatto ambientale notevole (per esempio per lo smaltimento dei pannelli solari o dei monopattini elettrici presentano complessità che non li rendono davvero ‘verdi’ lungo tutto il ciclo produttivo)
- i controlli mancati nei Paesi in via di sviluppo porta all’impossibilità di avere dati completi sulle loro emissioni
- accordi con altri Paesi necessari ma anche pericolosi perché questi ultimi trattengono una grossa fetta di mercato e potrebbero comportarsi in maniera non corretta
- difficoltà per i paesi Europei di trovare altri metodi di produzione di energia pulita in breve tempo e a costi contenuti
Qualche speranza arriva dalla Commissione Europea:
- il Net Zero Act, che vuole ridurre la dipendenza dell’UE dall’estero
- il Critical Raw Materials Act, che vuole cercare nuove partnership per l’arrivo di materie prime in Europa. Questa misura si spera possa favorire anche il riciclo dei materiali usati.
Transizione Energetica
La transizione energetica è il processo di passaggio da un sistema energetico basato sui combustibili fossili (come petrolio, carbone e gas) a un sistema energetico basato sulle fonti di energia rinnovabile (come sole, vento e acqua). Nel corso della sua evoluzione, l’uomo ha rivolto i suoi sforzi verso lo sviluppo di tecnologie e invenzioni utili a garantire l’approvvigionamento di risorse ad alto contenuto energetico, tali da consentire lo sviluppo della società e dell’economia globale così come la conosciamo oggi.
In particolare, le fonti di carbonio fossile, come il carbone e il petrolio, sono diventate le principali risorse che hanno permesso la crescita economica, grazie alla loro capacità di fornire grandi quantità di energia a supporto dei processi industriali. Tuttavia, queste risorse energetiche non sono rinnovabili, ponendo un serio problema al sostentamento delle economie mondiali nel momento in cui ci si avvicina al loro esaurimento.
Perché è necessaria la transizione energetica?
1. Cambiamenti climatici: i combustibili fossili emettono gas serra che contribuiscono ai cambiamenti climatici.
2. Esaurimento delle risorse: i combustibili fossili sono una risorsa limitata e si stanno esaurendo.
3. Inquinamento ambientale: i combustibili fossili producono inquinamento ambientale che danneggia la salute umana e l’ambiente.
Le fonti di energia rinnovabile sono:
1. Energia solare: l’energia prodotta dal sole.
2. Energia eolica: l’energia prodotta dal vento.
3. Energia idroelettrica: l’energia prodotta dall’acqua.
4. Energia geotermica: l’energia prodotta dal calore della Terra.
Come si sta realizzando la transizione energetica?
1. Investimenti nelle energie rinnovabili
2. Sviluppo di tecnologie sempre più efficienti
3. Politiche governative che promuovono la transizione energetica.
La transizione energetica richiede anche un cambio di paradigma nel modello di produzione e crescita economica della società umana, dove la riduzione degli sprechi e l’uso di risorse non inquinanti, assieme all’adozione di modelli di economia circolare, possono contribuire a ridurre l’inquinamento ambientale.
L’investimento degli Stati europei nella transizione energetica per far fronte al cambiamento climatico sta portando a produrre sempre più energia dalle fonti rinnovabili. Dal 2004 al 2022, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è passata dal 16% circa dell’energia elettrica totale consumata in Europa, al 40%, superando la produzione derivata da fonti fossili ed energia nucleare.